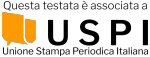Alla sempiterna domanda sull’utilità della storia, su se la storia ci insegni qualcosa, Alessandro Barbero ha saggiamente risposto che beh, sì, almeno una cosa la storia sembra proprio averla insegnata: che non è una buona idea invadere la Russi. Si può precisare: almeno da occidente (ai mongoli invece andò bene). Largamente note sono la campagna di Napoleone e la campagna di Hitler. Ma prima di loro, un altro protagonista della storia, sebbene ora meno universalmente noto, aveva portato alla rovina la propria nazione nel “folle volo” di voler far guerra alla Russia in casa sua, nelle sue immense pianure, nei suoi inclementi climi.
Questo primo protagonista è Carlo XII, re di Svezia. Con l’immagine che oggi ha la Svezia, e anche per l’oggettiva esiguità della sua popolazione, è difficile pensare che per quasi un secolo questo paese fu tra le più grandi, ambiziose, bellicose e temute potenze d’Europa. Ma mentre la Svezia, nella seconda metà del XVII, sembrava riuscire a solidificare il suo dominio nei territori che oggi grosso modo comprendono la Germania nord-orientale, la Polonia e le repubbliche del Baltico orientale, la Russia, in particolare ad opera di Pietro I, si affacciava dal suo peculiare medioevo alla civiltà moderna e si proponeva a sua volta, con il suo ben più massiccio peso territoriale e numerico, come potenza egemone dell’area. La “Grande guerra del Nord” ingaggiata dai due monarchi è la dimostrazione che il genio militare non basta se non è accompagnato da freddo calcolo dei rapporti di forza e anche da quel briciolo di fortuna che serve sempre.
Il Pietro I di cui sopra è Pietro il Grande per i russi e Deli Piotr, ossia Pietro o’ Pazz’, per i turchi. Sì, scusate, non resisto in tentazione di tradurlo in napoletano, suona troppo meglio che in italiano. Del resto “pazzo” in turco può, come in questo caso, avere una simpatica connotazione positiva (per esempio delikanlı, letteralmente “dal sangue pazzo”, vale per “giovane”). E come al solito per dare sapore all’eloquio noi italiani dobbiamo cercare altrove che nella nostra lingua ufficiale.
Salito al trono nel 1697, all’età di 15 anni, il giovane Carlo dovette fin dall’anno 1700 subire gli attacchi di russi, danesi e sassoni. Il giovanissimo sovrano riuscì a sconfiggerli tutti. Ma qualche anno dopo, nel 1708, decise di passare all’offensiva, di marciare su Mosca. Sconfitto, dopo iniziali vittorie, alla battaglia di Lesnaja, e mentre i russi ricorrevano alla tattica che avrebbero regolarmente ripetuto in séguito, quella della “terra bruciata”, anziché rinunciare deviò a sud verso l’Ucraina, dove contava di collegarsi con le forze ribelli del capo cosacco Ivan Mazeppa. Qui un inverno particolarmente aspro fece strage dell’esercito svedese, che fu definitivamente distrutto nella lunga battaglia di Poltava (giugno 1709). Ferito, Carlo XII riuscì a varcare il confine con l’Impero Ottomano con poche centinaia di soldati. Fino al 1714 rimase nella cittadina di Bender, in Bessarabia (Moldavia), recandosi talvolta a Istanbul, in una condizione prima di dorata ospitalità, poi, per la crescente riluttanza della corte ottomana a “sfruculiare” la Russia, di dorata prigionia. In quel 1714 riuscì a rientrare in incognito nei suoi possedimenti. Morì nel 1718, sotto le mura della fortezza di Frederiksten, nella Norvegia che cercava di riportare sotto la sovranità svedese.
Che cosa c’entra tutto questo con Johann Sebastian Bach? C’entra, perché Johann Jacob, il fratello maggiore di quello che per noi è tout-court Bach, fu tra quei pochi superstiti svedesi che si salvarono assieme al loro sovrano e convissero con lui nell’esilio.
Johann Sebastian fu uno dei circa cinquanta Bach tra musicisti e compositori che per parecchie generazioni si susseguirono in Germania. Uomo di musica fu anche Johann Jacob. Su un piano ben diverso, egli condivideva evidentemente con il fratello quell’irrequietezza che lo portò a rifiutare il destino tipico dei Bach, ossia trovarsi un buon posto presso qualche corte o qualche chiesa e lì fermarsi per sempre. Dopo varie peregrinazioni, entrò come oboista nella banda militare di Carlo XII e, come abbiamo detto, lo seguì nelle sue terribili peripezie (e il fatto che sia sopravvissuto fa pensare che, come il fratello minore, avesse un fisicaccio). Uno dei figli di Johann Sebastian, dopo di lui il più grande di tutti i Bach, ossia Carl Philipp Emanuel, che fu anche la “memoria storica” della stirpe, scrisse che “Da Bender, raggiunse Costantinopoli e vi fu istruito nel flauto dal famoso flautista Buffardin, che vi era giunto al seguito di un ambasciatore francese, e questa notizia la dette lo stesso Buffardin, una volta che a Lipsia si trovò in visita presso J.S. Bach”. Tornato in Svezia un po’ prima del suo sovrano, Johann Jacob morì a Stoccolma nel 1722.
Johann Jacob ha una sua peculiare importanza nell’opera del genio fratello: il Capriccio sopra la Lontananza del Fratello Dilettissimo (BWV – Bach Werke Verzeichnis – Catalogo delle Opere di Bach 992), scritto nel 1704 quando lui si allontanò dalla natia Turingia per mettersi al servizio del re svedese, è l’unica composizione giovanile di Bach sicuramente databile (il titolo dell’opera non deve far pensare che Johann Sebastian si mise a fare i capricci perché il fratello se ne era andato; “capriccio” indicava un brano o una composizione dallo schema libero, atipico; famosi il “capriccio – largo” della sinfonia n. 86 di Haydn e i capricci per violino solo di Paganini).
Il Bach universalmente noto non vide mai né Svezia né Russia, però un rappresentante della Russia fu per lui una figura molto benefica. Il conte Hermann Carl von Keyserling, ambasciatore dell’Impero Zarista presso la corte di Dresda, fu suo grande estimatore e fece sapere agli arcigni membri del consiglio comunale di Lipsia, pentitissimi di averlo assoldato, che dovevano lasciarlo stare (leggete fino in fondo). Nel 1740 il conte, che sapeva di essere in credito con lui, gli “mandò a bottega” il giovane talentuoso Johann Gottlieb Goldberg. Il conte soffriva di insonnia e Goldberg doveva suonare nella stanza accanto per rilassarlo (oggi lo fanno i set di musica rilassante su youtube; perlomeno, non doveva suonare sempre le stesse cose, mentre per alcuni anni Farinelli, il più grande castrato di tutti i tempi, dovette cantare per mesi e mesi, sia pure strapagato, sempre le stesse arie per Filippo V di Spagna che era deli… e basta). Goldberg disse a Bach che il conte avrebbe gradito un po’ di musica nuova. Bach non se lo fece ripetere. E così il giovincello se ne tornò a Dresda con l’Aria con diverse variazioni per tastiera a due manuali, comunemente note come Variazioni Goldberg, uno dei massimi monumenti del genio umano. Ascoltate le due celeberrime esecuzioni di Glenn Gould, quella del 1955 e quella del 1981; meglio ancora, guardate il video di quella del 1981, in particolare la parte finale. Il conte doveva essere davvero uno che di musica capiva: ebbe la rara dote di comprendere immediatamente che per lui era stato composto un capolavoro, se lo fece suonare in continuazione e inviò a Bach una bella somma.
Un’altra connessione orientale di Bach è quella col caffè. Una delle tarde composizioni di Bach, infatti, è la cantata profana (ossia non di argomento religioso) intitolata Cantata del Caffè, composta tra il 1732 e il 1734. Tra tutte, è quella con cui il sommo compositore più si avvicinò a un mondo in cui non volle mai entrare, quello dell’opera. Eppure ci andava, all’opera, ci andava a Dresda, ci portava i figli, dicendo “Andiamo a sentire le belle canzoncine di Dresda?”. Dunque verso lo “stile facile” degli operisti alla moda aveva questo atteggiamento: non di disprezzo, ma di consapevolezza, un po’ serena un po’ malinconica, che tanto era impossibile a lui “scrivere facile” quanto agli altri raggiungere la sua profondità.
La Cantata del Caffè è in effetti una mini-opera comica senza scene e costumi. Ed è una satira della moda, che si andava diffondendo, di bere quella nuova bevanda forte e scura, di provenienza orientale. Non è vero che l’Occidente ne ebbe contezza solo dopo che sacchi pieni di chicchi di caffè furono trovati nel campo ottomano dopo il fallito assedio di Vienna del 1683, ma è vero che fu subito dopo quel famoso episodio bellico che a Vienna furono aperte le prime caffetterie e che il caffè, da infuso esotico “di nicchia”, diventò in Occidente un vero e comune genere di consumo. Protagonista dell’operina è una giovincella oltremodo dedita al consumo del caffè. Il padre, brontolone e conservatore, ha due preoccupazioni: la prima, consueta, è quella di trovarle marito; la seconda, quella di distoglierla dalla sua mania. La giovincella è disposta ad accasarsi, ma fa spargere la voce che pone come condizione per sposarsi che il marito le permetta di continuare a degustare a piacimento la sua amata bevanda. Alla fine il padre cede. Abbiamo già parlato di insonnia: non chiedete come facesse poi la ragazza a dormire (fuor di scherzo, sarebbe interessante sapere come a quell’epoca fossero valutate e gestite le conseguenze dell’assunzione del caffè). Morale, cantata assieme nel finale dal padre, dalla figlia e dal narratore: niente resiste alla moda e alle donne.
La musica è piacevolissima e rivela un lato umoristico e scanzonato di Bach che in realtà è presente in molti dei suoi pezzi strumentali; la sapienza contrappuntistica e armonica delle sue composizioni è al servizio di tutta la gamma dei sentimenti umani; quello che di certo manca nella musica di Bach, anche nella festosità, anche nella gaiezza, anche nell’umorismo, è la banalità. Lodevole mancanza!
In effetti Bach, al contrario dell’immagine stereotipata del placido artigiano tutto casa, chiesa e organo, fu un uomo dal carattere sanguigno ed emotivo (forse esagerando, Buscaroli usa gli aggettivi “manesco e guappesco”), un assenteista inveterato, che negli ultimi vent’anni della sua vita abbandonò pressoché completamente la musica da chiesa, riciclando e riadattando continuamente vecchie musiche (anche altrui, e molto spesso profane) per adempiere ai suoi doveri contrattuali che, immediatamente pentitosi delle condizioni accettate, fece sempre di tutto per non rispettare. E’ duro, durissimo da digerire, per noi che abbiamo introiettato l’idea romantica dell’opera d’arte, che la maggior parte della musica di opere come la Passione secondo Matteo o la Messa in Si Minore sia il riciclaggio di pagine già composte per versi e contesti diversi.
Se, inoltre, per motivi oggettivi, Mozart non possiamo immaginarcelo vecchio, Bach non riusciamo a immaginarcelo giovane. E invece più della metà della sua produzione rientra nei quasi 36 anni che corrispondono alla vita di Mozart. Nei primi anni di Lipsia, dal 1723 al 1727, scrive ancora molto. Poi si dedica a poche grandi opere, tra cui le menzionate variazioni. Nel 1747 si reca in visita a Berlino, alla corte di Federico II di Prussia, buon flautista, che aveva assunto Carl Philipp Emanuel, e improvvisa una difficilissima fuga su un tema molto bello fornitogli dal re. Torna a Lipsia, medita su quel tema e scrive la Musikalische Opfer, che in Italia è abitualmente conosciuta come Offerta Musicale ma che andrebbe più propriamente tradotta con Omaggio Musicale. Decenni dopo, re Federico e racconta dell’incontro, cantando il proprio tema, al barone Van Swieten, emissario dell’Impero Asburgico. Van Swieten è la grande figura connettiva della vita di Haydn, Mozart e Beethoven. E’ lui che fa studiare Bach a Mozart, è per lui che Mozart realizza versioni modernizzate, oggi diremmo arrangiamenti, degli oratori di Händel (altra cosa su cui oggi pudicamente si sorvola, perché “pare brutto”).
Tra gli ultimi Bach, intanto, soprattutto grazie a Carl Philipp Emanuel, sopravviveva, circonfuso di orgoglio familiare, il ricordo del Bach avventuriero, quello che si era spinto ai confini dell’Europa seguendo il “folle volo” del suo sovrano.
*Questo articolo riutilizza in parte due articoletti pubblicati nel 2011 sulla “Gazzetta di Istanbul”.
**Fabio L. Grassi, Associate Professor of History of Eastern Europe